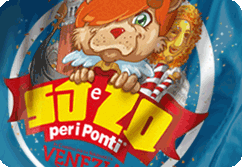Itinerario culturale “Su e Zo per i Ponti” 2025
Pellegrinaggi a Venezia:
un cammino tra fede e antiche tradizioni della Serenissima
a cura del Servizio Comunicazione turistica della Città di Venezia
Introduzione – Mappa – Punti di interesse
Se c’è una città che ha saputo trasformare ogni celebrazione in uno spettacolo indimenticabile, quella è Venezia. Nel corso della sua storia millenaria, la Repubblica di San Marco ha collezionato più processioni di qualsiasi altro stato europeo, intrecciando cerimonie civiche e riti religiosi in un caleidoscopio di colori, costumi e scenografie. Dallo Sposalizio del Mare, in cui il Doge rinnovava i voti della Serenissima con l’Adriatico, alle visite a chiese e monasteri, come San Giorgio Maggiore o San Rocco, tutto era un trionfo di arte e potere.
Quando nel fatidico 1797 Venezia perse la sua libertà politica, svanirono anche quei cortei sontuosi. Oggi, per celebrare il Giubileo 2025, con questo itinerario riscopriamo le antiche processioni attraversando i luoghi di Venezia più conosciuti e quelli fuori dai soliti percorsi. Iniziamo dalla Chiesa di Santa Maria Formosa, legata alle primissime Feste delle Marie, per poi seguire le tracce del solenne corteo del Doge, che nella maggior parte delle cerimonie si concludeva in piazza, a Palazzo Ducale e in Basilica di San Marco.
Tappa imperdibile sono poi le Scuole Grandi, che innalzavano palchi mobili ornati di allegorie preziose e personaggi viventi, trasformando le calli in un teatro a cielo aperto.
E anche se i secoli sono passati, a Venezia sopravvive ancora quello stesso incanto durante la Festa del Redentore, in luglio, e la Madonna della Salute, in novembre. Tra pellegrinaggi, ponti votivi e riti antichi, la città riaccende la sua anima più vera, regalando un’esperienza che coniuga devozione, storia e un fascino senza tempo.
Mappa
Introduzione – Mappa – Punti di interesse
Punti di interesse
Introduzione – Mappa – Punti di interesse
1. BASILICA DI SAN MARCO / San Marco
In arrivo!
2. CHIESA DI SANTA MARIA FORMOSA / Castello
Tra le celebrazioni più antiche della Serenissima c’è la Festa delle Marie, che cadeva in pieno Carnevale. Famosa in tutta Europa, richiamava in città numerosissimi ospiti, tanto che di questa festa si ricorda anche Giovanni Boccaccio nel suo Decameron. Nati come riti religiosi, i ludi mariani affondano le proprie radici nell’XI secolo, quando il 30 gennaio di ogni anno, per tre o più giorni, solenni processioni in onore della Madonna attraversavano la città e culminavano il 2 febbraio, festa della Purificazione della Vergine. In questa giornata un corteo su barche toccava tre luoghi simbolici come la chiesa di San Pietro di Castello, il Palazzo Ducale e la chiesa di Santa Maria Formosa, il più antico tempio veneziano dedicato alla Vergine.
Le protagoniste erano le Marie, dodici statue lignee, riccamente adornate con corone d’oro e gemme, abiti intessuti d’oro e pettorali ricamati, oggetti preziosi provenienti dal Tesoro di San Marco. Nei giorni della festa erano custodite nelle case delle famiglie di due contrade diverse della città, sorteggiate ogni anno. Il momento più spettacolare della celebrazione era la processione acquea nel giorno della Candelora: le Marie, circondate da dame e damigelle, e seguite dall’imbarcazione del vescovo, venivano trasportate su particolari barche, chiamate scaule, dalla Chiesa di San Pietro di Castello fino a Piazza San Marco, dove il doge si univa alla solenne cerimonia. Tutto il corteo, con il Bucintoro in testa, entrava in Canal Grande e raggiungeva la chiesa di Santa Maria Formosa, seguito da innumerevoli barche. La gente assiepava le rive e dai palazzi addobbati con drappi e tappeti, dame e damigelle sfarzosamente vestite partecipavano alla festa. Una volte giunte in chiesa, le Marie venivano benedette. Dopo la messa, secondo alcuni documenti storici, il doge ritornava a palazzo e offriva un banchetto a tutti coloro che avevano partecipato alla festa sul Bucintoro.
In concomitanza della celebrazione si correvano anche regate di voga: anzi, sembra che le regate abbiano avuto inizio proprio dai ludi mariani! Si trattava però di gare tra imbarcazioni a cinquanta remi e non tra barchette leggere, come avverrà poi dal Quattrocento.
La tradizione popolare vuole che la nascita di questa festa sia legata al salvataggio di giovani spose veneziane rapite dai pirati istriani, ma le fonti storiche rivelano una realtà diversa. La sua origine risale ai riti processionali e ai drammi liturgici, spettacoli teatrali molto diffusi per secoli in Italia e in Europa. Con il tempo, l’aspetto religioso lasciò spazio ai divertimenti mondani, fino alla soppressione della festa nel 1379, ritenuta troppo costosa per la Repubblica. Della celebrazione rimase la visita annuale del doge alla chiesa di Santa Maria Formosa la vigilia della Purificazione della Vergine. Per l’occasione la chiesa veniva addobbata con grande sfarzo e nel campo antistante e sul ponte si svolgeva una sagra con giochi e balli popolari. L’ultima andata dogale fu quella di Ludovico Manin nel 1797.
Oggi, rinata nel Carnevale di Venezia, la Festa delle Marie continua a incantare cittadini e visitatori, riportando in vita lo splendore di una tradizione secolare.
Secondo la leggenda, la chiesa di Santa Maria Formosa venne fondata nel 639 da San Magno su indicazione della Vergine apparsagli in sogno. Ricostruita nel 1492 da Mauro Codussi, custodisce capolavori di Vivarini, Palma il Vecchio e Tiepolo. Il campanile barocco (1688) reca una testa grottesca, creduta scudo contro il demonio che si dice amasse suonare le campane.
Per informazioni e visite: https://chorusvenezia.org/visita/chiesa-di-santa-maria-formosa/
3. SANTUARIO DI LUCIA / Cannaregio
A pochi passi dalla stazione di Venezia Santa Lucia, si trova un luogo di devozione che custodisce un tesoro prezioso: le reliquie di Santa Lucia. La martire siracusana, simbolo di luce e speranza, riposa in questo santuario, la chiesa di San Geremia, dopo un lungo viaggio attraverso il Mediterraneo.
Secondo la tradizione era il 13 dicembre del 304 quando Lucia morì, sottoposta a crudeli torture, vittima delle persecuzioni contro i cristiani. Le sue spoglie rimasero nella città natale fino al 1039, quando il generale bizantino Giorgio Maniace le portò a Costantinopoli. Ma fu la Serenissima, nel 1204, ad appropriarsene durante la Quarta Crociata, portandole a Venezia per volere del doge Enrico Dandolo.
La prima dimora veneziana della santa fu la chiesa di San Giorgio Maggiore, ma nel 1279 un tragico incidente segnò il destino delle reliquie: durante un pellegrinaggio, il mare mosso rovesciò alcune imbarcazioni e molti devoti annegarono. Per evitare altre tragedie, il Senato veneziano decise di trasferire il corpo nella chiesa di Santa Maria Annunziata, a Cannaregio. Il 18 gennaio 1280 le spoglie vennero trasferite con una solenne processione.
Una nuova chiesa, intitolata a Lucia e dove furono definitivamente deposti i suoi resti mortali, fu consacrata nel 1313 e quindi annessa a un convento. Qui la santa siracusana rimase per secoli, fino a quando le trasformazioni urbanistiche dell’Ottocento ne decisero nuovamente il destino. Tra il 1861 e il 1863, chiesa e convento vennero demoliti per fare spazio alla nuova stazione ferroviaria, quella che oggi prende il nome di Venezia Santa Lucia: il collegamento su rotaia rivoluzionava l’accesso alla città, non più dal mare, ma dalla terraferma. Non solo: si avviò anche la costruzione di nuove grandi vie, Lista di Spagna e Strada Nova, con l’idea di continuare fino a San Marco per poterci arrivare in carrozza. Esiste un quadro di Francesco Guardi che ci mostra come si presentava la chiesa conventuale di Santa Lucia prima della sua demolizione. Ancora oggi nel piazzale della stazione è visibile una lapide, incastonata nella pavimentazione, che ricorda il luogo in cui si trovava la chiesa ormai scomparsa.
Le reliquie di Santa Lucia furono allora traslate con una solenne processione, l’11 luglio 1860, dalla chiesa a lei dedicata nel non lontano tempio di San Geremia, dove sono custodite tuttora. Assieme al corpo della santa si sono salvati marmi e decori, tra cui anche diverse tele di Palma il Giovane, che sono serviti per erigere la nuova cappella. Con la traslazione delle sante reliquie, la chiesa intitolata a San Geremia sin dal Mille acquistò anche il titolo di Lucia.
Ma anche qui la pace fu turbata da un clamoroso furto: nel novembre 1981, due ladri armati di pistola rapirono il corpo, ritrovato dopo un mese in un’isola della Laguna. Le spoglie furono ricollocate al loro posto il 13 dicembre, giorno della festa liturgica. Oggi Santa Lucia riposa in una teca protetta da vetro antiproiettile e sistema di allarme, mentre migliaia di fedeli continuano a recarsi in pellegrinaggio per rendere omaggio alla giovane martire, che da nove secoli veglia su Venezia e sul mondo intero.
Curiosità: nel 1955, il futuro papa Giovanni XXIII commissionò una maschera d’argento che ricopre il volto della santa, riproducendo i tratti ispirati alla sua iconografia tradizionale. Ogni decennio, le reliquie vengono portate in pellegrinaggio a Siracusa, l’ultima volta nel 2024.
Oltre alle spoglie di Santa Lucia, questa chiesa ha custodito per sette secoli e mezzo anche quelle di San Magno, vescovo di Oderzo ed Eraclea, morto nel VII secolo. Inizialmente a Eraclea, il corpo fu traslato qui il 6 ottobre 1206 dal doge Pietro Ziani. Vi è rimato fino al 1956, quando è ritornato ad Eraclea.
La chiesa di San Geremia merita una visita anche per la sua caratteristica “doppia facciata”, una sul canale di Cannaregio e l’altra su campo San Geremia. Il campanile romanico in cotto è uno dei più antichi di Venezia. Il Santuario di Santa Lucia è aperto tutti i giorni: 9.30 – 13.00 / 14.00 – 17.00.
Per informazioni e visite: https://www.santuariodilucia.it/
4. SCUOLA GRANDE SAN GIOVANNI EVANGELISTA / San Polo
La Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, fondata nel 1261, resta ancora oggi una delle più prestigiose confraternite della Serenissima, custode di una tradizione che continua a incantare e affascinare.
Ogni anno, il 14 settembre, la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista celebra con solennità la Festa dell’Esaltazione della Santa Croce, una delle ricorrenze più antiche di Venezia.
Secondo la tradizione, fu Sant’Elena, madre dell’imperatore Costantino, a ritrovare la Croce di Cristo il 14 settembre del 320. In Oriente, questa celebrazione è considerata alla pari della Pasqua e si intreccia in origine con la consacrazione delle basiliche costantiniane sorte sul Golgota e sul Santo Sepolcro.
La Scuola Grande di San Giovanni Evangelista custodisce questa devozione dal 1369, quando Philippe de Mézières, gran cancelliere dell’Ordine di Cipro e Gerusalemme, donò due preziosi frammenti della Croce a Andrea Vendramin, allora Guardian Grande della confraternita. Questi frammenti, incastonati in un raffinato reliquiario gotico in argento dorato e cristallo di rocca, sono protagonisti di una solenne processione che attraversa la città dalla chiesa dei Frari a quella di San Giovanni Evangelista.
Nel periodo napoleonico, il reliquiario rischiò di essere trasferito alla Zecca per essere fuso, ma venne salvato da Giovanni Andrighetti, ultimo Guardian Grande dell’epoca, e successivamente restituito alla Scuola dagli eredi tramite l’allora Patriarca di Venezia, cardinale Pietro La Fontaine. Nonostante le soppressioni napoleoniche del 1806, la devozione popolare non si interruppe: già nel 1807, con la riapertura al culto della Chiesa di San Giovanni Evangelista, la reliquia tornò a essere esposta il 14 settembre e nella Domenica delle Palme.
Oggi, il reliquiario è custodito nell’Oratorio della Croce, all’interno del complesso monumentale della Scuola Grande, e nel giorno della Festa, dopo l’ostensione nella Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, il reliquiario viene portato in processione, issato su un soler settecentesco, sorta di portantina, e coperto da un prezioso baldacchino, anch’esso settecentesco, fino alla monumentale sala capitolare della Scuola Grande, dove si svolge una solenne celebrazione con la partecipazione di fedeli, autorità e confratelli delle Scuole Grandi veneziane.
Questa reliquia ha ispirato uno dei più straordinari cicli pittorici del Rinascimento veneziano: qui realizzano i propri teleri Gentile Bellini, Vettor Carpaccio, Lazzaro Bastiani, Benedetto Rusconi, detto il Diana, e successivamente anche Tiziano.
Oggi le cinque Scuole Grandi attive a Venezia sono splendidi complessi monumentali e musei aperti al pubblico, straordinariamente ricchi di tesori artistici. Ai tempi della Serenissima le Scuole Grandi sono sorte in origine come confraternite di cittadini laici che si riunivano nel nome di un santo patrono per dedicarsi alla devozione e alla beneficenza a favore dei poveri. Nel tempo, le Scuole hanno fatto erigere grandiosi edifici per le loro confraternite, impreziositi dai capolavori di grandi artisti. Ogni Scuola è organizzata secondo una struttura piramidale che riprende, in piccolo, quella istituzionale della Repubblica di Venezia. Al vertice vi è un Guardian Grando, eletto periodicamente dal Capitolo Generale, ovvero la riunione di tutti i confratelli. Alla gestione delle attività partecipa anche l’organo dirigenziale della Banca e Zonta.
Le cinque Scuole Grandi ancora attive a Venezia sono:
Scuola Grande di San Teodoro (www.scuolagrandesanteodoro.it)
Scuola Grande di San Giovanni Evangelista (www.scuolasangiovanni.it)
Scuola Grande di San Marco (www.scuolagrandesanmarco.it)
Scuola Grande di San Rocco (www.scuolagrandesanrocco.org)
Scuola Grande dei Carmini (www.scuolagrandecarmini.it).
5. CHIESA DI SAN ROCCO / San Polo
In arrivo!
6. SCUOLA GRANDE DEI CARMINI / Dorsoduro
In arrivo!
7. BASILICA DELLA MADONNA DELLA SALUTE / Dorsoduro
Nel giugno del 1630 Venezia fu travolta da una nuova ondata di peste, ancor più letale di quella del 1575. Il doge Nicolò Contarini fece voto di erigere una chiesa dedicata alla Vergine, invocandone la protezione.
Nella primavera del 1631, la città finalmente respirò. Il primo aprile fu posata la prima pietra della Basilica della Salute, vicino alla Dogana da Mar. La processione inaugurale, ben 700 partecipanti con torce e candele accese, attraversò un ponte di barche allestito sul Canal Grande.
La prima visita votiva del doge avvenne il 28 novembre 1631, tra solenni festeggiamenti in Piazza San Marco, adornata con arazzi, cuori d’oro, tappeti e dipinti. Nel porticato delle Procuratie Nuove fu eretto un palco, da cui un araldo annunciò la fine della pestilenza, tra rintocchi di campane e fuochi d’artificio. Seguì una messa cantata, diretta da Claudio Monteverdi, in San Marco. Da qui la processione si incamminò con in testa le Scuole Grandi e il corteo del doge a chiudere, fino alla chiesa votiva, ancora in costruzione, addobbata con stoffe preziose e illuminata da ceri.
La basilica, progettata da Baldassare Longhena, fu consacrata nel 1687. La sua maestosa cupola domina il Bacino di San Marco, custode dell’icona della Madonna della Salute, giunta da Candia nel 1670.
Ogni 21 novembre Venezia rinnova la sua devozione: un ponte votivo conduce i fedeli alla basilica, mentre il campo antistante si anima con bancarelle di frittelle, frutta caramellata e zucchero filato.
All’interno si ammirano capolavori di Luca Giordano, Palma il Giovane, Morlaiter, Bon e Lombardo. La sacrestia maggiore custodisce dodici opere del Tiziano, un Tintoretto e altri tesori.
Per informazioni e visite: https://basilicasalutevenezia.it/
8. CHIESA DEL SANTISSIMO REDENTORE / Dorsoduro – Giudecca
Il Redentore è la festa più attesa dai veneziani, quella che trasforma il bacino di San Marco in un teatro a cielo aperto e illumina la notte di luci e colori. Questa festa affonda le radici nel 1576, anno in cui, nel pieno di una delle più devastanti pestilenze dell’età moderna, il Senato della Serenissima, nel tentativo di placare il morbo, fece un voto solenne: costruire un tempio di ringraziamento e celebrare, ogni anno, una grande processione. Oggi, quell’antico rito è diventato uno degli eventi più spettacolari della città.
La peste, scoppiata il 25 giugno 1575, aveva già decimato un terzo della popolazione, nonostante il rigido isolamento degli ammalati nei Lazzaretti. Nel 1577, con il declino dell’epidemia, la Serenissima onorò il voto e il 3 maggio posò la prima pietra del tempio disegnato da Andrea Palladio. Il 21 luglio dello stesso anno, la prima processione dogale attraversò un imponente ponte votivo, sostenuto da oltre 80 galee e barconi, che collegava la Piazzetta San Marco alla chiesa di San Giovanni alla Giudecca.
Alla solenne processione presero parte le sei Scuole Grandi con ceri accesi, oggetti preziosi dei loro tesori e allegorie viventi. Seguivano frati con stendardi e reliquie e il clero veneziano, accompagnati dai cantori della basilica marciana. Quindi era la volta del patriarca di Armenia e di quello di Venezia. La piazzetta si trasformò in uno scenario sontuoso: arazzi ricoprivano le botteghe sotto i portici della Libreria, mentre stendardi dorati e festoni di frutta e fiori adornavano le colonne e gli archi.
All’ingresso del ponte, sotto un arco trionfale, il doge fu accolto con salve d’artiglieria, squilli di trombe e un’esplosione di giubilo da parte del popolo, assiepato ovunque, anche sulle barche. Sulla Giudecca, una chiesa provvisoria accoglieva il rito, preludio alla costruzione del tempio.
Da allora l’andata ebbe luogo ogni anno la terza domenica di luglio.
Dal 1578, due ponti galleggianti furono allestiti per facilitare il passaggio: uno da Santa Maria del Giglio all’opposta riva del Canal Grande, l’altro dalle Zattere alla chiesa del Redentore. Già sotto la Repubblica, la celebrazione si arricchì di momenti mondani: la vigilia era segnata da una festosa cena, a base di anatre arrostite e sogliole in saòr, con abbandonante vino di Trani. Il popolo vegliava tra canti e suoni fino all’alba, su imbarcazioni ornate con palloncini di carta multicolori, coperte di frasche e fiori, in quella che divenne la “notte famosissima“. La domenica si svolgeva la processione votiva, mentre il lunedì, il Redentoretto, era dedicato ai festeggiamenti popolari della Giudecca.
Dopo la metà dell’Ottocento, la celebrazione si fuse con la sagra di Santa Marta, una festa sull’acqua che si teneva il 29 luglio nel Canale della Giudecca, di fronte alla chiesa dedicata alla santa. Con la costruzione della Stazione Marittima sullo spiazzo antistante la chiesa, dove culminava la sagra, questa scomparve, lasciando il Redentore come unico grande evento notturno sull’acqua.
Ancora oggi, alla vigilia del Redentore, la sera del sabato, uno spettacolo di fuochi d’artificio illumina il bacino di San Marco e il canale della Giudecca. Le celebrazioni iniziano già il venerdì con l’inaugurazione del ponte votivo da parte delle autorità civili e religiose, in processione per rinnovare il secolare omaggio della città al Redentore, secondo il voto formulato dal doge Alvise Mocenigo più di quattro secoli fa. Oggi il ponte non è più fatto di barche, ma è una struttura galleggiante in legno e acciaio che, con i suoi 334 metri di lunghezza, unisce la Fondamenta delle Zattere e la chiesa del Redentore alla Giudecca. La domenica, le acque del Canale della Giudecca si animano con le attesissime Regate del Redentore, tre emozionanti gare di voga su pupparini e gondole, tipiche imbarcazioni veneziane. A conclusione, la Santa Messa Votiva nella chiesa del Redentore e la tradizionale benedizione della folla da parte del patriarca.
Oltre la festa, la chiesa del Santissimo Redentore rimane un’icona dell’architettura rinascimentale. Capolavoro di Andrea Palladio, completato dopo la sua morte nel 1580 da Antonio da Ponte, il tempio esprime la perfetta armonia del classicismo. Il suo interno, essenziale e grandioso, ospita capolavori di Paolo Veronese, Tintoretto, Francesco Bassano, Paolo Piazza e Jacopo Palma il Giovane. La sacrestia custodisce tesori inestimabili, tra cui il Battesimo di Cristo del Veronese e preziosi reliquiari e opere devozionali legate alla storia della chiesa, come la Madonna che adora il Bambino dormiente di Antonio Vivarini.
Per informazioni e visite: https://chorusvenezia.org/visita/chiesa-del-santissimo-redentore/
9. CHIESA DI SAN GIORGIO MAGGIORE / San Marco – San Giorgio Maggiore
Per secoli, la sera di Natale, alla vigilia di Santo Stefano, il bacino di San Marco si illuminava di un corteo maestoso: il doge, accompagnato dai suoi quarantun elettori, dai patrizi con incarichi di governo, dagli ambasciatori e da un’infinità di gondole e imbarcazioni ornate di fanali, solcava le acque della laguna per raggiungere l’isola di San Giorgio Maggiore. Sulle bricole, torce di corda impeciata, i cosiddetti “ludri”, trasformavano la notte in giorno, proiettando bagliori sull’acqua. Le dame veneziane, velate di nero e adornate di gioielli, prendevano posto nelle loro gondole de casada, aggiungendo un’aura di misteriosa eleganza alla processione.
Sbarcato sull’isola, il Serenissimo veniva accolto dai soldati dalmati in abiti di gala, tra il suono di musiche militari. Seguiva una solenne processione guidata dall’abate e dai monaci, fino alla basilica, dove si teneva una breve cerimonia. Lì, tra le navate della chiesa benedettina, il doge assisteva ai vespri e venerava le reliquie del protomartire.
Il giorno successivo, in onore della translatio delle reliquie di Santo Stefano, il doge tornava a San Giorgio Maggiore per assistere alla messa solenne, celebrata in una chiesa sfarzosamente adornata di arazzi e tessuti preziosi. Dopo la celebrazione, l’abate offriva un banchetto nel convento, usanza che, dal 1562, fu sostituita da un donativo annuale alla corte dogale e ai musici della cappella marciana.
Le celebrazioni culminavano con un sontuoso banchetto a Palazzo Ducale, segnando simbolicamente l’inizio del Carnevale: i teatri riaprivano e le maschere tornavano ad animare la Piazza San Marco.
Secondo una leggenda, la venerazione del doge per San Giorgio Maggiore ebbe origine con l’arrivo a Venezia delle reliquie di Santo Stefano. La narrazione vuole che un monaco benedettino di San Giorgio Maggiore, Pietro, durante un soggiorno a Costantinopoli, riuscisse a trafugare la cassa contenente il corpo del santo, nascosta per otto anni nel monastero ospitante. Giunto il momento propizio, la reliquia fu imbarcata su una nave diretta a Venezia. Una violenta tempesta rischiò di far naufragare l’imbarcazione, ma le preghiere dei passeggeri rivolte al santo salvarono il viaggio. In cambio, venne fatto voto di fondare una confraternita in suo onore e di visitare la sua tomba ogni anno. Giunta a destinazione, la reliquia venne collocata nella chiesa dell’abbazia benedettina, da allora dedicata ai santi Giorgio e Stefano.
Oggi, la Basilica di San Giorgio Maggiore è aperta ai visitatori tutti i giorni dalle 9 alle 18. Il campanile, ricostruito nel 1791 dopo il crollo dell’originale quattrocentesco, regala una vista mozzafiato sulla città e sulla laguna. Tra gli spazi privati del Monastero, visitabili su prenotazione, spiccano la Sacrestia antica progettata da Andrea Palladio, la Cappella della Deposizione con l’ultima opera di Tintoretto, e la Cappella del Conclave, che nel 1800 ospitò l’elezione di papa Pio VII. Nella Sala del Conclave si ammira anche il celebre San Giorgio che uccide il drago di Vittore Carpaccio, datato 1516.
Per informazioni e visite: https://www.abbaziasangiorgio.it/
10. CHIESA DI SAN NICOLÒ / Lido di Venezia
In arrivo!
Scopri tutti gli itinerari per esplorare una Venezia diversa promossi dalla campagna di sensibilizzazione #EnjoyRespectVenezia della Città di Venezia. Adotta comportamenti consapevoli e rispettosi del patrimonio culturale e naturale di Venezia e della sua laguna, sito tutelato dall’UNESCO.
Servizio Comunicazione turistica della Città di Venezia:
www.enjoyrespectvenezia.it
turismosostenibile@comune.venezia.it
Facebook: @DetourismVeneziaOfficial
Instagram: @Detourismvenezia
X: @DetourismVenice
Photo credits:
Comune di Venezia.